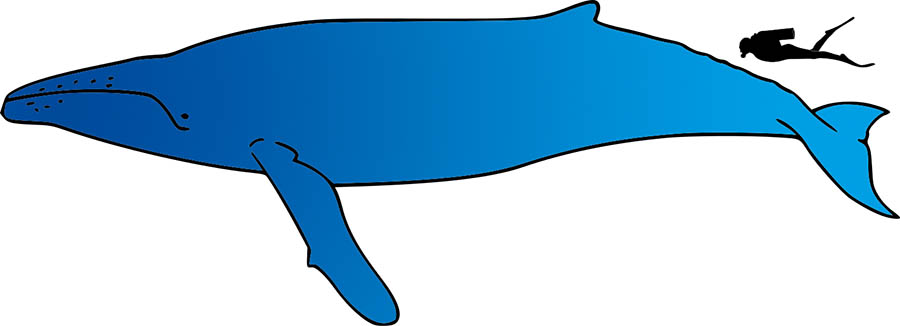Un’operazione di rilancio della ripulitura dei fondali portuali, denominata “Clean water”, è stata la degna conclusione di MareNordEst 2018. Un altro successo per l’ormai celebre manifestazione triestina legata alle attività sopra e sotto il “mare sostenibile”.
La Redazione
Grande successo anche quest’anno per la tre giorni di MareNordEst, la manifestazione incentrata su tutto quanto ruota attorno al mondo del mare svoltasi stavolta l’8, 9 e 10 giugno nella prestigiosa cornice della Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste con ingresso libero e aperto a tutti, cittadini e turisti.
«Il mare sostenibile» è stato il tema cardine di un evento che anche nel 2018 proponeva tre giorni ricchi di eventi e incontri aperti, tali da coinvolgere le principali figure professionali che ruotano attorno all’ambiente marino in vari ambiti, nell’intento di interessare non solo gli operatori del settore, ma anche i cittadini di ogni età, evidenziando le migliori conoscenze e competenze attualmente presenti sul territorio e tracciando alcune prospettive per il futuro.
Promossa da Trieste Sommersa Diving, associazione senza fini di lucro, in co-organizzazione con il Comune di Trieste e giunta con crescente successo a questa VII edizione, la manifestazione – particolarmente attesa in quanto ormai fortemente integrata nel tessuto economico e culturale cittadino – da sette anni si pone l’obiettivo di rappresentare un preciso punto di riferimento per la promozione della “cultura del mare” e del dialogo sulle prospettive di sviluppo economico, occupazionale, scientifico e turistico connesse, nell’intero Nord Est.
Il programma articolato e completo degli incontri ed eventi vari che avevamo anticipato è stato puntualmente portato a compimento. Anche per questo, più che rientrare nei dettagli delle varie iniziative svolte – com’è noto, si è spaziato da prestigiose proiezioni per i ragazzi delle scuole a vari stage per giornalisti di mare e presentazioni librarie, nonché il concorso fotografico subacqueo internazionale Memorial Moreno Genzo, le premiazioni connesse ecc – desideriamo sottolineare il rilievo della manifestazione conclusiva, proprio quella “Clean water” che ha assunto tanto spessore, sia nella realizzazione e nello svolgimento pratico, sia a livello simbolico, dato il periodo di speciale rilancio mediatico di problematiche ambientali marine come quella delle plastiche e microplastiche disperse in mari e oceani.
Ebbene, colpisce in maniera particolare l’elenco analitico di quanto i moltissimi gruppi di volontari cercatori subacquei hanno recuperato dal fondale accanto al Molo Audace, tutto catalogato grazie all’apporto della ricercatrice dell’OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Federica Nasi e di Manuela Rizzo, laureanda in Geologia all’Università degli Studi di Trieste… sentite qua: «437 bottiglie di vetro; 64 lattine; 23 bottigliette di plastica e 84 oggetti tra sacchetti e altro; 79 bicchieri di vetro; 6 oggetti di ceramica tra cui piatti; 1 sanitario (tazza WC); 1 scaldabagno; 2 biciclette; 1 skateboard; 1 marmitta; 14 ombrelli; 1 tappeto; 1 tesi di laurea in doppia copia; 28 cellulari tra cui un iPhone; 1 orologio; 2 ancore; 1 gonfalone pubblicitario; 1 bandiera italiana; 1 dentiera; 1 mostrina dell’esercito Reggimento Piemonte Cavalleria; 3 batterie di auto; 7 paia di occhiali; 2 volanti; 1 bottiglia di vino; 1 bottiglia di liquore; 4 tra borsette e portafogli; 2 documenti; 22 tra cartelli segnaletica stradale e transenne; 2 coni stradali; 2 copertoni di camion; 1 paio di scarpe; 1 carrello della spesa; vario materiale da pesca; 17 corde; materiale elettrico e ferroso; tessuti vari; 37 cavi elettrici; 2 sedie da esterni… delle quali una poltroncina del Caffè degli specchi il cui titolare, per festeggiare l’insperato ritrovamento, ha offerto un simpatico e scherzoso brindisi ai presenti e incuriositi passanti».
Si può affermare senza timori di smentite che questa grande e spettacolare IV Operazione “Clean Water” 2018 abbia dato nuovo slancio e notorietà anche nazionale alle operazioni di pulizia dei fondali che, come genere, era andato un po’ appannandosi agli occhi dei subacquei negli anni precedenti; mentre stavolta la partecipazione è stata estesissima e assai più sentita, vi hanno preso parte offrendo un insostituibile contributo su base volontaria ben 16 associazioni da tutta la regione e anche dal Veneto: Scuola Cani Salvataggio Fvg, Corpo Pompieri Volontari Trieste – F.F – PGD, Immersione con i caschi, Circolo Sommozzatori Trieste, Sub Sea, Fare Ambiente, Cravatte Rosse, Y-40, Sistiana Diving, Murena, La Triblù, Acquamission, Acquatick Dream, Blue Bubble e Scuba Tortuga per complessivi 202 partecipanti, tutti volontari, tra subacquei, apneisti e personale a terra, 110 dei quali si sono immersi. Alla presenza anche di 2 agenti a bordo di altrettante moto d’acqua della Polizia di Stato, come a voler sancire ulteriormente l’ufficialità dell’iniziativa anche dal punto di vista dell’operatività pratica sul campo.
Ma addirittura l’istituzionalità dell’evento è emersa in tutta la sua evidenza, grazie alla presenza anche del vicepresidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato, dell’onorevole Massimiliano Panizzut, del Vicesindaco Paolo Polidori, dell’assessore all’Innovazione del Comune di Trieste, Serena Tonel e dei consiglieri comunali Monica Canciani e Radames Razza. Una partecipazione particolarmente attiva all’operazione e perciò degna di nota speciale è stata quella dell’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro che, indossando la muta da sub e immergendosi in mare lui stesso per offrire un suo personale contributo pure “da subacqueo”, ha poi parlato anche di «interessante esperienza grazie alla possibilità di lavorare con un team costituito da persone entusiaste e competenti che amano il mare, lo sport e la cura per l’ambiente». «Questa iniziativa – ha affermato concludendo Scoccimarro – rappresenta un messaggio importante per sensibilizzare le persone sul tema dell’educazione ambientale, la quale deve partire soprattutto coinvolgendo i più giovani attraverso le scuole».
Particolare soddisfazione è stata espressa al termine dagli organizzatori di Trieste Sommersa Diving (Roberto Bolelli, Alessandro Damico ed Edoardo Nattelli) che hanno dato appuntamento all’edizione 2019 che presterà – è stato già prontamente anticipato – ancora più attenzione ai temi della salvaguardia e alla cultura del mare e al coinvolgimento del mondo delle scuole, come auspicato pure dagli amministratori regionali e comunali intervenuti.
A conclusione delle operazioni sono seguite nello stesso specchio di mare, apprezzatissime come sempre dal pubblico dei moltissimi astanti della domenica mattina, le spettacolari dimostrazioni di salvataggio in mare con l’ausilio di 11 unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio Fvg.
È stata quindi la volta, sempre presso la Centrale Idrodinamica in Porto Vecchio, delle premiazioni condotte da Adriano Toffoli e Roberto Lugnani, coordinatori della IV Operazione Clean Water, conferite al gruppo più numeroso (Circolo Sommozzatori Trieste con 45 partecipanti alle operazioni), a quello con la maggior presenza femminile (ancora CST con 15 donne presenti) al sub o apneista più anziano (Berardo Degiorgio) e al più giovane (Samuele Maura) e a chi ha raccolto l’oggetto più strano (lo skateboard recuperato da Fabrizio “Zorro” Zarotti) e all’associazione che si è maggiormente distinta (Corpo Pompieri Volontari Trieste – F.F – PGD presenti con 10 unità).
Fondamentale il supporto offerto da AcegasApsAmga, che, per agevolare le operazioni dei sommozzatori, ha provveduto a posizionare un contenitore scarrabile in prossimità del molo Audace per permettere il conferimento dei particolari rifiuti rimossi dal fondale marino portuale. Al termine, gli addetti della Multiutility hanno provveduto a rimuoverlo avviando correttamente a recupero tutti i materiali rinvenuti.
Ulteriori informazioni, immagini e video sono presenti sulla pagina facebook (www.facebook.com/pages/Mare-Nordest-Trieste/694493867279347) e sul sito (www.marenordest.it).
Mare Nordest è realizzato in co-organizzazione con il Comune di Trieste, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gode del sostegno di AcegasApsAmga, Bignami Sub e Scuba Store.
Mare Nordest ringrazia per il supporto e la vicinanza la Direzione Marittima – Capitaneria di Porto di Trieste, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Trieste Terminal Passeggeri, Unione Regionale Fvg Corpo Pompieri Volontari P. Gasilci – F. Feuerwehr e tutte le associazioni dedite alla subacquea che ogni anno partecipano con entusiasmo alla manifestazione.




 «Con piacere comunichiamo a tutti che sono state ripristinate le boe nell’area di Tutela Biologica delle Tegnue di Chioggia, ora fruibile da quanti volessero immergersi. L’operazione è stata conclusa nella giornata di sabato 30 giugno e la situazione verrà costantemente aggiornata nella pagina del nostro sito
«Con piacere comunichiamo a tutti che sono state ripristinate le boe nell’area di Tutela Biologica delle Tegnue di Chioggia, ora fruibile da quanti volessero immergersi. L’operazione è stata conclusa nella giornata di sabato 30 giugno e la situazione verrà costantemente aggiornata nella pagina del nostro sito